Artist:
Marcello Fera, Gabriele Mirabassi, Alberto Casadei, Nathan Chizzali, Silvio Gabardi, Francesco Dillon
Title:
Marcello Fera: Piccoli Arcani, Chamber Music 2003 - 2023
Year Of Release:
2024
Label:
Da Vinci Classics
Genre:
Classical
Quality:
FLAC (tracks)
Total Time: 1:13:03
Total Size: 382 MB
WebSite:
Album Preview
Tracklist:1. Marcello Fera, Gabriele Mirabassi & Alberto Casadei – Diaphonia, for Violin, Clarinet and Cello (06:22)
2. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – No. 1 (00:50)
3. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – No. 2 (02:18)
4. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – No. 3 (02:11)
5. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – No. 4 (02:33)
6. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – No. 5 (03:04)
7. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – No. 6 (04:44)
8. Marcello Fera & Nathan Chizzali – In risposta, for Violin and Cello (02:55)
9. Aframunda, for Violin (03:10)
10. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – Ode, for Violin, Cello and Double-Bass (04:12)
11. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – Lidia Spina, for Violin, Cello and Double-Bass (04:16)
12. Interludio alla voce, for Violin (04:03)
13. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – Selvagia Fera, for Violin, Cello and Double-Bass (04:49)
14. Marcello Fera & Gabriele Mirabassi – Hi Jack, for Violin and Clarinet (01:25)
15. Marcello Fera & Alberto Casadei – Perdue, for Violin and Cello (04:10)
16. Sensa Sciou, for Violin (03:23)
17. All'intorno, for Violin (02:26)
18. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – Siebzieg Karat, for Violin, Cello and Double-Bass (02:30)
19. Marcello Fera, Nathan Chizzali & Silvio Gabardi – That's it, for Violin, Cello and Double-Bass (03:34)
20. Segno, for Violin (02:36)
21. Marcello Fera & Francesco Dillon – La sacra conversazione, for Violin and Cello (07:22)
‘Music,’ said Claude Debussy, ‘is that thing that is born from silence, pauses for a few moments in front of us and then returns again to silence’. Sound, in other words, is nothing more than a pause, a brief appearance, enclosed between two silences: first it is only expectation, later it is only nostalgia. And it is in that momentary pause, in that lingering that possesses no time of its own, but only the time of perception, that it acquires its own precarious, fragile, transient meaning. This tripartite architecture, made up of a slender central body (the sound) and two very long, immense lateral wings (the silences), also seems to represent, faithfully enough, the recent itinerary of Marcello Fera’s musical writing. Some of the pieces featured in this new album entitled Piccoli Arcani actually come from an earlier work entitled Canti dal silenzio (Songs from Silence): a cycle, but above all a recital, that brings together twelve pieces for solo violin composed within a short space of time, between 2020 and 2022. The composer himself recounts the genesis of these pieces in a recent interview: ‘In 2020 (during the pandemic, ed.) I found a way, every morning, for a month and a half, to give a short half-hour concert in Meran inside a church that I discovered was open. No publicity, no advertising. A meditation, or if you prefer a practice. This is how Songs from Silence was born’. An individual, private silence, therefore, preceding the act of composition and performance: ‘The encounter with silence,’ says Marcello Fera, ‘is invariably the experience that one has, that I have, at the act of composing. To be faced with this dense core of silence, even quite frightening, from which you begin to extract something that then expands and becomes a piece’. But the silence of that suspended time also acquired – given the ‘historical’ circumstances in which the cycle was born – a collective dimension, that which extinguished the vox publica of the national community during the harshest months of confinement. And it is perhaps no coincidence that it was precisely the conjunction of these two silences that led Marcello Fera to finally reunite, in his arms, the figure of the composer with that of the performer. This was common practice, almost the only one, in seventeenth century (his favourite); later it disappeared, between the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth, due to the performer’s increasingly cumbersome presence.
A trace of this reductio ad unum, as well as an irresistible attraction to the vocal matrix of violin writing, can be found in all five of the tracks from the source of the Songs from Silence. This happens with the fragmentary, broken, interrupted chant of Segno, for example, in which the violin intones a series of rapid, dazzling cells separated by more or less ‘interminable’ silences. It is as if, after asserting its voice, the instrument waits for its own echo to expand in space or for a response that should or could come from that same space. A space of which sound nevertheless seeks to take possession, a space it tries to inhabit with difficulty. Or the “song of poetry” that nourishes Interlude to the voice. Not a metaphorical and abstract voice, but the dense and real voice of poetess Roberta Dapunt, whose resonance, phonetic diagram or perhaps more simply sound image the piece seeks to represent. Or again the song in the form of Aframunda’s dance, which reveals a soft and exhausted sensuality beyond the appearance of a ‘whimsical’ melodic procession, in which the flavours of an abstract folk dance intertwine with a more concrete Bachian jig. Finally, the last two ‘children’ generated by Canti dal silenzio refer to a sort of circular and continuous chant, without pauses or breaths, similar to that of the infinite declinations of harmonic singing: Sanza sciou (in Genoese, Breathless), which, after a brief initial prelude, appears as a perpetual motion that, remaining anchored in an obsessive rhythmic cell, holds its breath until the end, when the chant dies in the violin’s barely murmured overtone harmonics. And finally All’intorno, another piece based on the ostinato technique: this time it is a micro-cell (generated by the note D that is continuously varied, but inexorably falls back on the starting sound) which is systematically iterated.
The other eleven minor arcana included in the sylloge belong to a much longer time span, namely the twenty years from the advent of the new millennium to the present day. From a strictly instrumental point of view, they represent a broadening of the sound spectrum with respect to the ‘solitude’ of the unaccompanied violin, including, without ever crossing the threshold of the small chamber ensemble, the violin, cello, clarinet, and double bass, in various combinations. Aesthetically and conceptually, however, they symbolically depict the ‘third time’ of Debussy’s allegory, namely the ‘return to silence’. Certainly not an ‘acoustic’ silence – on the contrary, Fera’s chamber music arcana burst with sound, living in a rich and generous sound dimension – but a conceptual silence. In other words, this is the migration – after the momentary epiphany of the ‘human’ (we might even say ‘humanistic’) sound – towards an ‘arcane’ sound. Here music – as the composer writes – ‘inhabits a dimension all its own, irreducible, despite us intimately recognising its logic, to being understood entirely through concepts and definitions’. In this immersion towards a new silence, three areas are drawn in which the ‘arcane voice’ makes its foretellings heard. Firstly, the secluded area of what might be called ‘stage music’, in which the constant, subterranean theatricality of Marcello Fera’s instrumental music clearly emerges: Diaphonia, a meditative and umbratile ‘nocturne’ for violin, cello and clarinet created as a sound counterpoint to a video shot by Elisabeth Hölzl inside the fish market in Catania. It is complemented by Due Vite, which instead constitutes the sound side of a melodrama taken from Danilo Montaldi’s Autobiografie delle leggera, a series of short stories dedicated to the so-called ‘ligera’ (i.e., the communities of petty criminals, thieves, and prostitutes widespread in Lombardy, between Milan and Cremona, until the early post-war period). The tale dedicated to Cicci, a prostitute who becomes the ‘respectable’ wife of a farmer, is reflected in an extended ‘recitation’ in the form of a suite for violin, cello and double bass that alternates different and contrasting moods: from the lively tango rhythm led by the violin in the two extreme sections to the mournful melos led by the cello in the central part. Two other pieces fall within the illustrious praxis of transcribing or rather transfiguring ancient music – a practice always cultivated by Fera with the instruments of dulcedo and subtilitas, sweetness and subtlety. Lidia spina for violin, cello and double bass, is the declination in the present tense of the ‘various and disparate’ affections present in Lidia spina del mio core, a piece by Claudio Monteverdi for soprano, alto, bass, two violins and continuo taken from the Scherzi musicali of 1607. On the other hand, Selvagia fera is the title, chosen with evident autonomic irony, of a suite that brings together the transcriptions of three 14th-century ballads by Francesco Landini. These transcriptions are literal, but with unpredictably “radical” sonorous outcomes, and they regard Selvagia fera, Muort’oramai and the celebrated Echo la primavera. A third group of pieces (including Ode, Hi Jack and Siebzieg Karat) belongs instead to the equally illustrious tradition of hommages, which from Josquin Desprez to György Ligeti has enjoyed and continues to enjoy constant fortune. In many cases, these are occasional pieces, but imbued with affections, intimate memories, signals, and sound cryptographies that are inscribed in the domain of a refined, exclusive ‘reserved music’. In a higher and equally reserved free zone, however, lies the precious stone of La sacra conversazione: a two-part invention for violin and cello that openly wants to be the sound paraphrase of Roberta Dapunt’s poetic text with which it shares (also) the title. A piece that is irreducible to any attempt at linguistic codification: it opens with a prelude of unusual phonic-acoustic harshness and then unfolds into a restless conversation in which the “sound word” emerges with difficulty, but with increasing acoustic definition, from the silence that generated it. And so it can only be the concluding, unspoken verses of The Sacred Conversation that draw, on the threshold between saying and not saying, the leave-taking from Piccoli Arcani: “I will give you impressions of grace, I will convert your smile into silences/that you have never known, that we will never know/ in exchange for all this you will save the loneliness that is in me/man who asks me for words”.
“La musica – diceva Claude Debussy – è quella cosa che nasce dal silenzio, sosta per qualche istante davanti a noi e poi torna nuovamente nel silenzio”. Il suono, in altre parole non è altro che una pausa, una breve apparizione, racchiusa tra due silenzi: prima è solo attesa, dopo è solo nostalgia. Ed è in quella sosta momentanea, in quell’indugio che non possiede un proprio tempo, ma solo il tempo della percezione, che acquista un suo precario, fragile, passeggero significato. Questa architettura tripartita, fatta di un esile corpo centrale (il suono) e di due lunghissime, smisurate ali laterali (i silenzi), sembra rappresentare, in modo sufficientemente fedele, anche l’itinerario recente della scrittura musicale di Marcello Fera. Una parte dei brani presenti in questa nuova silloge discografica intitolata Piccoli Arcani proviene in realtà da un lavoro precedente che si intitola Canti dal silenzio: un ciclo, ma soprattutto un recital, che raccoglie dodici pezzi per violino solo composti in un breve arco di tempo, tra il 2020 e il 2022. La genesi di questi brani la racconta lo stesso compositore in una intervista recente: “Nel 2020 (durante la pandemia, ndr) ho trovato il modo, ogni mattina, per un mese e mezzo, di fare un piccolo concerto di mezz’ora all’interno di una chiesa di Merano che ho scoperto essere aperta. Niente pubblicità, niente rivendicazioni. Una meditazione, o se preferite una pratica. Così sono nati i Canti dal Silenzio”. Un silenzio individuale, privato, dunque, che precede l’atto della composizione e dell’esecuzione: “Il confronto con il silenzio – dice ancora Marcello Fera – è immancabilmente l’esperienza che si fa, che io faccio, all’atto del comporre. Stare di fronte a questo nucleo denso di silenzio, anche piuttosto spaventoso, dal quale cominci ad estrarre qualche cosa che poi si espande e diventa un brano”. Ma il silenzio di quel tempo sospeso ha acquisito – date le circostanze “storiche” in cui il ciclo è nato – anche una dimensione collettiva, quella che ha spento la vox publica della comunità nazionale nei mesi più duri del confinamento domestico. E non è forse un caso che proprio la congiunzione di questi due silenzi abbia indotto Marcello Fera a riunire finalmente, nelle sue braccia, la figura del compositore con quella dell’interprete. Una prassi comune, pressoché esclusiva, nel suo prediletto diciassettesimo secolo che poi si è dissolta, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, a causa della presenza sempre più ingombrante che ha acquistato la figura dell’interprete.
Una traccia di questa reductio ad unum, nonché una irresistibile attrazione per la matrice vocale della scrittura violinistica, si trovano in tutti e cinque i brani che provengono dalla fonte dei Canti dal silenzio. Il canto frammentario, spezzato, interrotto di Segno, ad esempio, in cui il violino intona una serie di cellule rapide e folgoranti separate da più o meno “interminati” silenzi: come se dopo aver affermato la sua voce lo strumento attendesse la propria eco espandersi nello spazio oppure una risposta che dovrebbe o potrebbe provenire da quello stesso spazio. Del quale il suono cerca comunque di impossessarsi, di abitare con fatica. Oppure il “canto della poesia” che nutre Interludio alla voce. Non una voce metaforica e astratta, bensì quella densa e reale della poetessa Roberta Dapunt, della quale il brano cerca di rappresentare la risonanza, il diagramma fonetico o forse più semplicemente l’immagine sonora. O ancora il canto in forma di danza di Aframunda che oltre la parvenza di un incedere melodico “capriccioso”, in cui si intarsiano i sapori di un astratto ballo popolare e di un una più concreta giga bachiana, rivela invece una morbida ed estenuata sensualità. Ad una sorta di canto circolare e continuo, senza pause e senza respiri, simile a quello delle infinite declinazioni del canto armonico, si rifanno infine gli ultimi due “figli” generati dai Canti dal silenzio: Sanza sciou (in genovese Senza respiro) che infatti si presenta, dopo un breve preludio iniziale, come un moto perpetuo che, rimanendo ancorato una cellula ritmica ossessiva, trattiene il respiro fino alla fine, quando il canto va a morire negli armonici sovracuti, appena mormorati, del violino. E per finire All’intorno, un altro brano basato sulla tecnica dell’ostinato: ad essere sistematicamente iterata è questa volta una micro-cellula generata dalla nota re che viene continuamente variata, ma ricade inesorabilmente sul suono di partenza.
Gli altri undici arcani minori inseriti nella silloge appartengono ad un arco temporale molto più esteso, ossia ai vent’anni che vanno dall’avvento del nuovo millennio fino ai giorni a noi vicini. Dal punto di vista strettamente strumentale essi rappresentano un allargamento dello spettro sonoro rispetto alla “solitudine” del violino non accompagnato, includendo, senza mai oltrepassare la soglia del piccolo ensemble cameristico, il violino, il violoncello, il clarinetto e il contrabbasso, in diverse combinazioni. Dal punto di vista estetico e concettuale, però, raffigurano simbolicamente il “terzo tempo” della allegoria debussiana ossia il “ritorno verso il silenzio”. Non certo un silenzio “acustico” ché anzi, al contrario, gli arcani cameristici di Fera scoppiano di suono, vivono in una dimensione sonora ricca e generosa, bensì un silenzio concettuale: la migrazione cioè – dopo l’epifania momentanea del suono “umano” (potremmo dire persino “umanistico”) – verso un suono “arcano”, appunto, in cui la musica – come scrive il compositore – “abita una dimensione tutta sua, irriducibile, nonostante noi ne riconosciamo intimamente la logica, ad essere compresa interamente attraverso concetti e definizioni”. In questa immersione verso un nuovo silenzio si disegnano tre aree in cui la “voce arcana” fa ascoltare i propri vaticini. In primis la zona appartata di quelle che potremmo chiamare “musiche di scena”, in cui emerge con chiarezza la teatralità costante e sotterranea della musica strumentale di Marcello Fera: Diaphonia, un “notturno” meditativo e umbratile per violino, violoncello e clarinetto nato come contrappunto sonoro ad un video girato da Elisabeth Hölzl all’interno del mercato del pesce di Catania, e Due Vite che invece costituisce il versante sonoro di un melologo tratto dalle Autobiografie delle leggera di Danilo Montaldi, una serie di brevi racconti dedicati alla cosiddetta “ligera” ossia alle comunità di piccoli criminali, ladri, prostitute diffuse in Lombardia, tra Milano e Cremona, fino al primo dopoguerra. Il racconto dedicato alla Cicci, una prostituta che diventa la moglie “rispettabile” di un contadino, si riflette in una estesa “recitazione” in forma di suite per violino, violoncello e contrabbasso che alterna umori diversi e contrastanti: dal vivace ritmo di tango condotto dal violino nelle due sezioni estreme fino alla melopea dolente guidata dal violoncello nella parte centrale. Altri due brani rientrano invece nella prassi illustre, sempre coltivata da Fera con gli strumenti della dulcedo e della subtilitas, della trascrizione o meglio della trasfigurazione delle musiche antiche: Lidia spina per violino, violoncello e contrabbasso è la declinazione al tempo presente degli affetti “vari e disparati” presenti in Lidia spina del mio core, un brano di Claudio Monteverdi per soprano, contralto, basso, 2 violini e continuo tratto dagli Scherzi musicali del 1607. Selvagia fera è invece il titolo, scelto con evidente ironia autonomastica, di una suite che riunisce le trascrizioni, fedeli ad syllabam, ma dagli esiti sonori imprevedibilmente “radicali”, di tre ballate trecentesche di Francesco Landini: Selvagia fera, Muort’oramai e la celeberrima Echo la primavera. Un terzo gruppo di brani (tra i quali figurano Ode, Hi Jack e Siebzieg Karat) appartiene invece alla tradizione altrettanto illustre degli hommage che da Josquin Desprez fino a Gyorgy Ligeti ha goduto e gode di una fortuna costante: pezzi d’occasione, in molti casi, intrisi però di affetti, memorie intime, segnali e crittografie sonore che si inscrivono nel dominio di una raffinata, esclusiva “musica reservata”. In una zona franca, più alta e altrettanto riservata, si incastona invece la pietra preziosa de La sacra conversazione: una invenzione a due voci per violino e violoncello che vuole essere, apertamente, la parafrasi sonora del testo poetico di Roberta Dapunt con il quale condivide (anche) il titolo. Un brano irriducibile a qualsiasi tentativo di codificazione linguistica che si apre con un preludio di insolita durezza fonico-acustica e poi si distende in una conversazione inquieta in cui la “parola sonora” emerge a fatica, ma con sempre maggiore definizione acustica, dal silenzio che l’ha generata. E non possono che essere dunque i versi conclusivi e non detti de La sacra conversazione a disegnare, sulla soglia tra il dire e il non dire, il congedo dai Piccoli Arcani: “Ti regalerò impressioni di grazia, convertirò il tuo sorriso in silenzi/che non hai mai conosciuto, che non conosceremo/in cambio di tutto ciò tu salverai la solitudine che è in me/uomo che mi chiedi parole”.
Guido Barbieri


![The Mood Mosaic - The Sexploitation (Pulp Grooves From The Mondo Porno Vault) (2025) [Hi-Res] The Mood Mosaic - The Sexploitation (Pulp Grooves From The Mondo Porno Vault) (2025) [Hi-Res]](https://www.dibpic.com/uploads/posts/2025-12/1766131648_uhod8d4qn4msi_600.jpg)
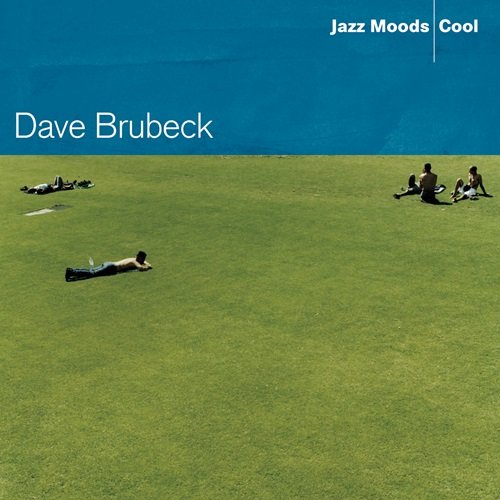


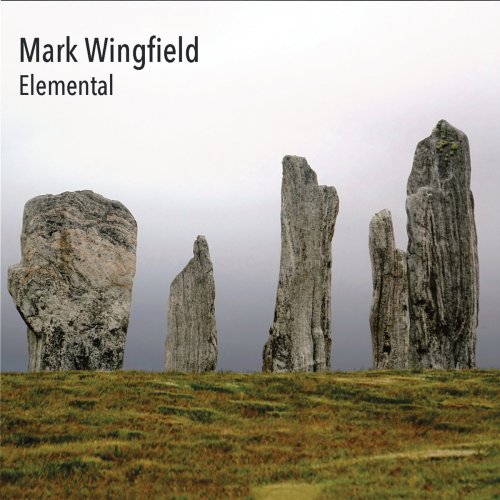


![Paul Mauriat - Mamy Blue (1971) [Hi-Res] Paul Mauriat - Mamy Blue (1971) [Hi-Res]](https://www.dibpic.com/uploads/posts/2025-12/1766140814_nqjtxk40yc4oi_600.jpg)
![Luizinho do Jêje, Marcelo Galter, Sylvio Fraga - Mocofaia (2024) [Hi-Res] Luizinho do Jêje, Marcelo Galter, Sylvio Fraga - Mocofaia (2024) [Hi-Res]](https://img.israbox.com/img/2025-12/19/ie15pqye9f7axu0oyf0ndsk7k.jpg)